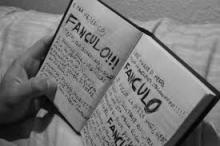La nuova riforma costituzionale riconferma la centralità del Parlamento; a una prima lettura, non si vede il motivo di tanta ostilità verso questa riforma.
In fondo, si tratta solo di una Costituzione scritta in modo confuso, che lascia troppi poteri al Senato, rischiando di creare nuove situazioni di ingovernabilità; nulla a cui non siamo già abituati. Ciò è riconosciuto anche da alcuni sostenitori della riforma.
Con la nuova riforma del Titolo V si ritorna al passato conflittuale tra Stato e Regioni?
Certamente sì, perché sono state abolite le materie concorrenti, ma l’ampliamento delle materie trasversali e la Clausola di supremazia (art 117 della nuova Costituzione) porteranno a una stagione di intensa conflittualità. Peccato, perché la conflittualità era avviata a soluzione, grazie alla intensa attività giurisprudenziale di questi ultimi quindici anni, ma anche su questo si può soprassedere.
Di positivo, per tanti, c’è la fine del bicameralismo paritario: il Senato non dovrà più dare la fiducia al Governo.
Non si supera il bicameralismo, perché il Senato conserva tanti e confusi poteri. Potrebbe costituire un elemento di ingovernabilità perché può legiferare su ogni materia (1° comma, art. 71) e, in ogni caso, deve obbligatoriamente esprimersi su leggi costituzionali, leggi elettorali, tutto ciò che riguarda le istituzioni elettorali, tutto ciò che riguarda l’Unione europea e la ratifica dei Trattati europei… e tanto altro ancora.
Pessimo il metodo di nomina dei senatori, demandato a ciascun Consiglio regionale che manderà in Senato, scegliendo con metodo proporzionale, qualche consigliere e un sindaco tra quelli della regione. Se avessimo già da tempo questo tipo di elezione, Minetti, Fiorito o il Trota… sarebbero potuti divenire senatori.
Un Senato che formalmente rappresenta le istituzioni territoriali, ma in realtà rappresenta le forze politiche di origine, senza un mandato politico e con il rischio che non ci sia una maggioranza politica. Un Senato che non potrà svolgere un raccordo tra l’attività legislativa delle regioni e tra le regioni e lo Stato, perché la riforma non individua strumenti concreti per realizzare questa funzione.
L’elezione del Senato rappresenta un vulnus per la democrazia: non si comprende perché una assemblea non eletta dai cittadini debba avere competenze differenziate che vanno dalla elezione del presidente della repubblica alla approvazione delle leggi costituzionali.
Una riforma monca, confusa che solleva un gran polverone quando per superare l’aspetto più condiviso bastava modificare due parole dell’art 94: il governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati (e non “delle due camere“).
Vista così, c’è già motivo di misurata preoccupazione.
Per comprendere appieno la portata della riforma, occorre leggerla insieme alla legge elettorale. Continua a leggere