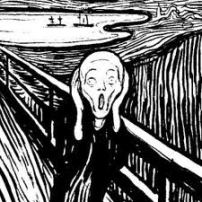Candidarsi alle elezioni politiche costa.
Forza Italia ha messo nero su bianco le proprie regole di ingaggio: euro 30.000 come una tantum alla accettazione della candidatura e euro 900 entro il 10 di ogni mese per gli eletti.
Ovviamente, il contributo può arrivare da terzi che così potranno anche approfittare delle agevolazioni fiscali. Tutto nella opacità più totale, come già avviene con le fondazioni politiche. Sui nomi dei finanziatori c’è sempre la massima riservatezza.
Costi importanti anche per la Lega; si vocifera di un contributo di euro 20.000.
Nel PD c’è un contributo mensile di euro 1.500 a carico degli eletti, ma si vocifera che per essere candidato in determinati collegi come capolista occorre essere generosi con il partito.
Il Movimento 5 Stelle prevede il taglio di una parte dello stipendio, che viene devoluto al fondo per l’accesso al microcredito, e un contributo di 300 euro mensili per sostenere l’associazione Rousseau.
Sparito il finanziamento pubblico ai partiti, dobbiamo fare i conti con il finanziamento privato al candidato, che poi saprà come ricompensare gli sponsor …
Mentre i vecchi partiti sono in crisi, si moltiplicano le fondazioni politiche, oltre 100, strettamente legate a politici e a strutture partitiche, ma solo poche pubblicano i bilanci e rendono noti i loro finanziatori. Nonostante i tanti progetti legislativi, siamo in un campo senza regole che non conosce trasparenza.
Il rischio maggiore è che le Fondazioni si trasformino in collettori di finanziamenti politici ed elettorali.
I finanziamenti possono arrivare anche da Enti pubblici e Istituzioni. Per esempio, il Ministero degli esteri retto da Alfano ha elargito un contributo di 20.000 euro alla Fondazione De Gasperi presieduta da Alfano …
In assenza di una legge regolatrice le fondazioni vivono nell’opacità. A ciò si aggiunga che manca in Italia una legge sulle lobby, nonostante siano stati presentati una cinquantina di progetti di legge!
Il quadro si complica se all’intreccio opaco tra gestione finanziaria dei partiti, ruolo delle fondazioni, finanziamenti pubblici discutibili … si aggiunge un sistema dei partiti per nulla democratico e trasparente nei suoi processi decisionali. Continua a leggere