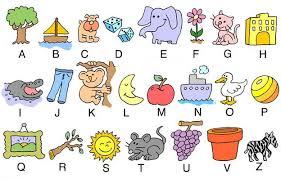Saprà il Senato correggere le vistose anomalie di Italicum, la nuova legge elettorale?
Su ciò confida Andrea Manzella.
Personalmente ne dubito perché sinora
- misero è stato il dibattito politico all’esterno del Parlamento e alla Camera dei Deputati
- povero il contributo della cultura e degli addetti ai lavori.
Tra questi addetti includo anche Andrea Manzella che oggi vede “errori evidenti di incostituzionalità” (come scrive su la Repubblica del 18 marzo 2014 a pagina 26) che sono lampanti da quando esiste la pessima proposta Italicum.
Il primo febbraio scrivevo polemicamente Perché non aboliamo la Corte Costituzionale prendendo spunto proprio da un articolo di Andrea Manzella: L’Italicum viaggia sui binari della Corte
E’ bello constatare che a distanza di mesi Manzella veda quel che era evidente sin da quando la proposta Italicum è sul tappeto; mi chiedo quale sia a questo punto il ruolo degli esperti, dei tecnici, dei professori.
Forse dobbiamo cominciare a dubitare di tanta parte del potere accademico troppo spesso solidale con il potere politico o di questo tributario.
Argomenta Manzella, benvenuto nel club, che il sistema delle soglie di sbarramento, elevate e differenziate tra chi corre da solo e chi corre in coalizione, è incostituzionale.
La soglia dell’8 per cento per chi corre da solo non è funzionale alla governabilità poiché questa è già garantita dal premio di maggioranza: comprime irragionevolmente la rappresentatività.
La soglia ridotta a 4,5% per chi si coalizza non aiuta la governabilità ma le ammucchiate coalizzate. Nel nostro sistema una coalizione può sempre rompersi e le forze politiche, la cui consistenza è stata aumentata dal premio, possono dare vita a una maggioranza diversa. Questo si è già verificato con i precedenti sistemi elettorali e oggi abbiamo in Parlamento formazioni governative che mai hanno avuto il supporto del voto popolare.
A Manzella continua a sfuggire che incostituzionale è il premio di maggioranza riservato a chi prende il 37%, nonostante sia previsto il doppio turno se nessuno raggiunge questa soglia.
Perché non prevedere il doppio turno in tutti i casi in cui nessuno prenda al primo turno il 50%+1?
Il principio del “minor sacrificio possibile” implica la ragionevolezza nel bilanciamento di interessi costituzionalmente legittimi e rilevanti.
Tale ragionevolezza è totalmente assente in Italicum.
Privo di logica e giuridicamente insensato prevedere il ballottaggio solo nel caso nessuno raggiunga la soglia del 37%. Andrebbe previsto il ballottaggio in tutti i casi in cui nessuno al 1° turno raggiunga la maggioranza assoluta.
In questo modo un partito sarebbe legittimato dal voto diretto popolare a governare poiché l’elettore ha scelto consapevolmente tra due ipotesi di maggioranza.
Nel nostro sistema il voto serve a rinnovare il Parlamento.
Illogico pertanto affidare il governo a una maggioranza relativa senza alcuna legittimazione diretta e dopo averla trasformata per magia in maggioranza assoluta.
Con questo sistema il rischio reale è una ulteriore compressione della libertà di scelta dell’elettorato che si troverà spinto, a suon di sondaggi, a votare i papabili al raggiungimento del premio, per evitare da un lato la dispersione del voto e dall’altro che il temuto avversario vinca al primo turno. Anche perché non sono consentite coalizioni dopo il primo turno.
Ancor più grave che Manzella continui a dare una lettura semplicistica e riduttiva della sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale quando affronta il tema delle preferenze.
Liberissimo Manzella di accontentarsi della “effettiva conoscibilità” dei candidati, ma non è assolutamente questo il punto che la Corte Costituzionale pone in rilievo quando censura il porcellum.
La Corte ha ricordato la sentenza 203 del 1975 nella quale, confermando la legittimità delle norme per la compilazione delle liste, affermava che quelle norme “non ledono affatto la libertà di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”.
Manzella ritiene che il richiamo di questa sentenza da parte della Corte sia un fatto casuale?
Ecco come la Corte si esprime riguardo alle norme che impediscono la scelta del candidato: “Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”
Ritenere, come fa Manzella, che sia sufficiente “l’effettiva conoscibilità dei candidati” per promuovere le liste bloccate ma corte è affermazione riduttiva del significato e della portata della sentenza della Corte. Tanto più che la Corte Costituzionale utilizza le citate parole sulla conoscibilità nell’ambito di un ragionamento in cui afferma: “In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).”
Analizziamo.
La Corte scrive che il sistema Porcellum è incomparabile con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate.
Se i collegi sono piccoli e i candidati pochi c’è la ragionevole possibilità che l’elettore possa conoscere i candidati e che questo garantisca la scelta e la libertà di voto. Tutto però va visto nell’insieme delle considerazioni svolte dalla Corte, senza tralasciare il come si giunge alla selezione dei candidati.
Sul punto la Corte scrive: “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.”
Di tutto ciò in Italicum non c’è traccia: l’articolo 49 della Costituzione resta inattuato, non c’è una disciplina che regoli l’assunzione di cariche di partito, che garantisca trasparenza e democrazia nei processi decisionali interni ai partiti.
Con Italicum tutto si riduce a rendere possibile la conoscibilità dei candidati, ma ciò non consente in ogni caso all’elettore di scegliere il rappresentante poiché
a) è escluso dalla selezione dei candidati
b) non può votare il candidato che preferisce
c) deve votare solo la lista
Quindi, liste corte o lunghe, si riconferma “che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini”, circostanza “che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”.
Quanto dovremo attendere perché Manzella si renda conto che Italicum è un porcellum con un traguardo da raggiungere per avere il premio?
Per certi versi peggio del porcellum perché arriva dopo oltre otto anni di argomentate critiche al porcellum e una sentenza della Corte Costituzionale che con semplicità, chiarezza e solide argomentazioni ha censurato i punti più significativi di quel sistema elettorale.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...