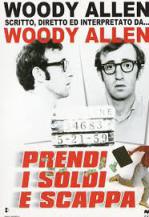@matteorenzi
Renzi, segretario del PD, sollecitando Letta ad abbandonare la guida dell’esecutivo, sbaglia nella forma e nei contenuti.
Letta non è primo ministro perché il PD lo ha messo lì ma perché dopo le fallimentari elezioni politiche del 2013, nella necessità di dare un esecutivo al Paese, è sembrato che intorno a Enrico Letta si potesse formare una maggioranza parlamentare in grado di sostenere l’esecutivo il tempo necessario per realizzare vaghe riforme e incerti programmi, aldilà della fumosità delle ampollose dichiarazioni da più parti rilasciate. Così è stato: il Parlamento con ampia maggioranza ha dato la fiducia all’esecutivo guidato da Enrico Letta.
Il governo Letta non è un monocolore DC (rinvio al periodo 1948 – 1963, legislature I – II – III e primo anno della IV), ma un governo espressione storica della diaspora DC.
A differenza del periodo storico citato, quando PRI, PLI e PSDI avevano l’unica scelta di stare con la DC o stare all’opposizione, adesso NCD, Casini e parte di SC hanno la possibilità di decidere se stare con il PD o stare con FI e il ricostituendo centro-destra.
Se decideranno di sostenere il passaggio da Letta a Renzi lo faranno esclusivamente per “senso di responsabilità” e per “il bene del Paese” sino alla approvazione della nuova scellerata legge elettorale.
Il giorno dopo avranno ampie e valide argomentazioni per affermare che il PD è inaffidabile e quindi toglieranno la fiducia al governo Renzi, portandoci a elezioni anticipate.
E Napolitano, in qualità di Presidente della Repubblica, non potrà che prenderne atto.
Renzi sta offrendo armi solidissime per ricompattare il centro-destra, dalla Destra di Storace alla Lega passando per Fratelli d’Italia, UDC, profughi da SC e forse qualche profugo finiano.
L’esecutivo Letta non sta certo brillando per l’attività sinora sviluppata e da adesso farà ancora peggio.
Ma cosa potrà fare Renzi con gli stessi alleati di Letta?
Assolutamente nulla, tranne ciò che si potrebbe fare con qualsiasi governo perché in realtà le proposte sul tappeto riguardano l’attività legislativa del Parlamento e non il governo.
Ci sono proposte di iniziative governative elaborate dal PD e bloccate da Letta?
Non risulta proprio.
Quindi?
Oltre a ricompattare il centro-destra e trasmettere la forte percezione di un PD democristianamente posseduto da logiche correntizie, Renzi non fa e non potrà fare in questa legislatura, con questo Parlamento.
Tranne l’ipotesi in cui Renzi non sia in grado di definire un programma preciso di governo e riforme con altri alleati che non siano il NCD e SC.
Ha Renzi l’appoggio e il sostegno di SEL e del M5S o di parte di esso per poter rinunciare a NCD e SC?
Se Renzi non ha questo piano di alleanze, alternativo a quello esistente, allora sta sbagliando tutto perché non è De Gasperi e nemmeno quel toscanaccio di Fanfani… è solo un renziano.