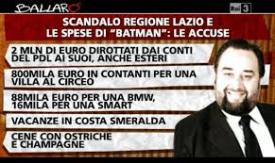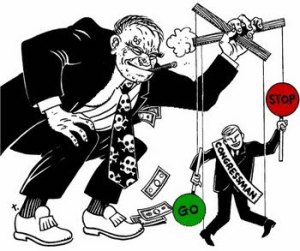Il bicameralismo perfetto non era molto gradito già ai tempi della Costituente. Allora i Costituenti non seppero trovare compromesso migliore tra le diverse posizioni; prevalse il timore di un esecutivo troppo forte – d’altra parte si usciva dal fascismo – e si presero decisioni che certamente privilegiarono la rappresentatività sulla governabilità.
In sintesi, la Costituzione prevede identici poteri per ciascuna delle due Camere che devono, entrambe, dare la fiducia all’Esecutivo (art. 94 Costituzione). Inizialmente prevedeva diversa durata per la legislatura del Senato e della Camera; tuttora prevede corpo elettorale diverso, assegnazione dei seggi su base regionale (art. 57 Costituzione), numero minimo di senatori per ciascuna Regione, anche senza diretta proporzione con la popolazione, cosicché Basilicata e Abruzzo hanno lo stesso numero di senatori sebbene la prima abbia la metà degli elettori della seconda.
L’eventualità che dalle elezioni non scaturisse una maggioranza di governo era ben presente sin dall’inizio e fu una consapevole scelta dei Costituenti: vollero che l’esecutivo fosse espressione del Parlamento, rappresentante della sovranità popolare.
Già nel 1953 si tentò di rafforzare la governabilità e la stabilità di governo modificando la legge elettorale. Tra infinite polemiche, la nuova legge fu approvata e passò alla storia come “legge truffa” perché alterava la proporzionalità della rappresentanza parlamentare assegnando un premio a chi avesse già conquistato la maggioranza assoluta. Il premio non scattò alle elezioni del 1953, la legge fu cancellata e si tornò alla legge precedente.
Così negli anni si cercò ancora di assicurare la governabilità agendo sempre sulla legge elettorale e lasciando inalterato l’assetto costituzionale, che rimane pur sempre a centralità parlamentare, vale a dire: gli elettori eleggono i parlamentari e questi decidono sul governo; il potere esecutivo è quindi nelle mani del Parlamento.
A forza di leggi elettorali che scimmiottavano sistemi maggioritari si è raccontata la favola del “governo eletto dal popolo” o del “premier voluto dagli elettori”. Continua a leggere